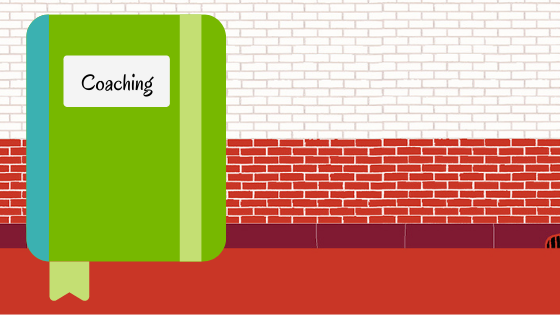
Sono un coach.
Questa è la mia risposta quando mi chiedono di cosa mi occupo.
La reazione del mio interlocutore oscilla tra il “beata te!” e “e lo chiami lavoro?”
Perché ti sto raccontando questo? Questo non capita se rispondo dicendo “sono un project manager”
La realtà dimostra che il coaching non è percepito come una professione vera e propria.
Il tema è caldo, sono anni che sento parlare di esigenza di regolamentazione di una professione che non è normata, che sento parlare di “fuffa coach” e di persone che si definiscono coach perché hanno frequentato qualche ora di workshop.
Come coach, come formatrice in una scuola di coaching e project manager ormai dedicata a progetti in ambito educational e empowerment della persona, sento la necessità di dire la mia.
I motivi per diventare coach
Negli ultimi anni ho incontrato molte persone che desiderano diventare coach e che intraprendono il percorso di studio per farlo. Se sei tra questi ti suggerisco per prima cosa di porti tre domande fondamentali:
Perché vuoi occuparti di coaching?
Hai sperimentato almeno un percorso di coaching come coachee?
Hai il desiderio di occuparti davvero delle persone?
(queste sono domande che dovresti anche fare al coach che stai cercando per te!)
Se la risposta alla prima domanda include qualcosa di simile
a “da giovane volevo fare lo psicologo” o “ho pensato anche al counseling ma la
scuola dura tre anni ed è troppo lunga”, lascia perdere.
Il coaching non è la versione light della psicologia.
Se rispondi alla seconda domanda chiedendoti perché ti sto ponendo questa domanda e non ritieni fondamentale essere stato coachee per scegliere questa strada, ti chiedo: come puoi sapere il potenziale del coaching se non lo hai provato sulla tua pelle? E ancora, a quali modelli ti riferirai per costruire il tuo modo di essere un professionista?
Se alla terza domanda ti viene in mente che in fondo sei “coach inside” perché aiuti da sempre le persone, sei un buon amico e dai una mano a chi hai intorno, scordati che questa tua caratteristica insieme a un corso di un anno e alle 100 ore di tirocinio sia sufficiente per fare di te un professionista.
Gli ingredienti della professione
Ora che ti detto quali sono i motivi sbagliati per scegliere di diventare coach, ti racconto quali sono secondo me gli ingredienti essenziali del lavoro:
Empatia, competenza, motivazione, studio, studio e studio e orientamento ai risultati.
In quali dosi?
Q.B. (quanto basta o, meglio, quanto soddisfa le tue esigenze e quelle dei tuoi clienti): ogni ingrediente deve essere dosato sulla necessità che può variare da momento a momento, ma anche da coachee a coachee.
Quindi?
Se vuoi una professione in cui occuparti degli altri, della loro realizzazione e della loro efficacia, stai facendo la scelta giusta.
Se desideri studiare, approfondire e non accontentarti mai della tua preparazione sei sulla giusta lunghezza d’onda, se sei il primo a credere e a mettere in pratica i buoni principi del coaching nella tua vita, potrai essere un buon coach.
Perché? Il punto è essere coach, anziché fare il coach!
E in questo concetto dell’essere coach entra il nostro impegno nel comunicare e vendere il nostro lavoro. Sono convinta che se la professione del coach non viene considerata seria quanto desideriamo, una parte della responsabilità è dovuta a come la nostra categoria si conforma a raccontarsi.
Possiamo contrastare il danno reputazionale che i fuffa coach portano alla professione solo distinguendoci e lavorando sulla serietà dei contenuti. Questo obiettivo si raggiunge studiando e approfondendo i temi che trattiamo e proponendo una chiave di interpretazione inedita, evitando il rischio di pubblicare l’ennesimo articolo uguale a mille già proposti dai nostri competitor. Questo, oltre a essere un buon principio di marketing, è un modo per mostrare la nostra presenza attiva nell’evoluzione della materia.
Le trappole della retorica dello story telling
Ancora più pericoloso è il modo in cui raccontiamo chi siamo e testimoniamo la nostra quotidianità da coach. Esiste una retorica archetipica dello storytelling del coach.
La triste storia del tristo * che diventa un coach felice
Ecco il plot di moltissimi “chi siamo” nei siti web di coach. Tipicamente si prende in prestito la progressione classica del viaggio dell’eroe, una triste situazione, la caduta, la riscossa e lo studio e …. Ecco a voi! Il coach è servito!
Questo modello è pericoloso quando è sbilanciato sull’importanza dell’esperienza di vita rispetto al valore delle competenze professionali. Sono consapevole che questo racconto è empatico, ci permette di parlare direttamente al nostro cliente, ma siamo sicuri di voler trasmettere l’idea che basta avere una storia più o meno (o diversamente) disgraziata (insoddisfacente, faticosa, frustrata) per fare il salto nel mondo del coaching, salvare se stessi e essere in grado di salvare gli altri? Vogliamo comunicare che siamo professionisti preparati ed efficaci o falliti in cerca di una seconda chance?
Non desidero sminuire l’importanza che la nostra esperienza individuale può avere nell’interpretazione della professione ma la storia di ognuno di noi è piena di successi e fallimenti, di cadute e di faticose eroiche rincorse. La nostra azione da coach è tutt’altra cosa: è frutto di competenze ed esperienza.
Cosa è più importante nel nostro racconto del chi siamo? Il nostro divorzio, licenziamento, burnout o quello che oggi sappiamo fare?
L’inganno della rilassata giornata del coach
Un altro punto scivoloso riguarda come raccontiamo la nostra quotidianità.
Come è la vita del coach? Non so rispondere a questa domanda in generale, ma so quello che vediamo tutti nei social. Una vita patinata, a contatto con le meraviglie della natura, in cui si sorseggiano tisane e the esotici, si fanno bagni rilassanti, si gode della bellezza del tramonto e si accendono candele profumate.
Quello che posso dirti con certezza è che la mia vita non è questa. Vivo in città, bevo caffè, qualche volta mi affaccio sul mio rumoroso cortile per capire chi e perché urla, e sono felice quando lavoro perché questo è un lavoro nutriente e sfiancante allo stesso tempo. La mia vita è regolata dall’agenda verde in cui segno gli appuntamenti a matita perché ci sono contrattempi che variano i piani. Gli spazi bianchi non sono per il riposo, sono per studio, per la promozione, per preparare eBook, lezioni ed esercizi o lavorare ai progetti europei (che sono l’altra metà della mia vita lavorativa).
Una professione non normata ma…
Questo articolo è molto lungo, ma voglio spendere ancora qualche parola sul tema del riconoscimento della professione. Ho la sensazione che spesso questo sia un alibi, che viene tirato in ballo per sollevarci dalla necessità di aderire a un codice etico che pur esiste e che viene insegnato in qualsiasi valida scuola di coaching (quello definito da INTERNATIONAL COACH FEDERATION).
Mi piacerebbe che il mondo del coaching prendesse spunto da quanto avviene nella realtà dei project manager, altra professione che non ha un albo di riferimento nazionale, ma che è forte di un presidio internazionale che include tra le best practice la diffusione della cultura del project management nel mondo.
Con questo spirito a fine 2020 ho deciso di richiedere il riconoscimento di AICP (Associazione Italiana Coach Professionisti) consapevole che questo non avrebbe rappresentato una stelletta da esibire sul bavero quanto l’impegno a contribuire alla crescita della cultura del coaching a partire dall’adesione al programma di aggiornamento necessario a mantenere i requisiti per essere socio.
Insomma, non fare il coach ma essere coach!
